Cluny e la filiazione cistercense
ORDINE CISTERCENSE
 La fondazione di Cîteaux Nove secoli
fa, nel 1098, il giorno 21 marzo, inizio della Primavera, festa
di san Benedetto e, in quell'anno anche Domenica delle Palme,
ventun monaci lasciarono il monastero di Molesme per fondare,
nella Borgogna francese, 20 Km. a Sud di Digione, un nuovo insediamento
monastico, che fu chiamato "Nuovo Monastero". A capo
dei 21 monaci c'era proprio l'abate di Molesme, Roberto, che aveva
avuto in precedenza l'approvazione del Legato del Papa, Ugo, Arcivescovo
di Lione. Più tardi il "nuovo monastero" prese
il nome di Cîteaux, dal nome della località, Cistercium,
in latino. Ecco, in poche parole, l'origine dei Cistercensi, che
tanto sviluppo dovevano avere nei secoli seguenti. Origini umili
e difficili, di uomini che disponevano di pochissimi mezzi, di
un terreno incolto e selvaggio, ricevuto in dono da Rainaldo,
visconte di Beaune, ma di un grande cuore e di una fede sicura,
sostenuti dal desiderio, coltivato da anni, di una vita monastica
solitaria e povera, fedele alla tradizione degli antichi, rappresentata
dalla Regola di san Benedetto.
La fondazione di Cîteaux Nove secoli
fa, nel 1098, il giorno 21 marzo, inizio della Primavera, festa
di san Benedetto e, in quell'anno anche Domenica delle Palme,
ventun monaci lasciarono il monastero di Molesme per fondare,
nella Borgogna francese, 20 Km. a Sud di Digione, un nuovo insediamento
monastico, che fu chiamato "Nuovo Monastero". A capo
dei 21 monaci c'era proprio l'abate di Molesme, Roberto, che aveva
avuto in precedenza l'approvazione del Legato del Papa, Ugo, Arcivescovo
di Lione. Più tardi il "nuovo monastero" prese
il nome di Cîteaux, dal nome della località, Cistercium,
in latino. Ecco, in poche parole, l'origine dei Cistercensi, che
tanto sviluppo dovevano avere nei secoli seguenti. Origini umili
e difficili, di uomini che disponevano di pochissimi mezzi, di
un terreno incolto e selvaggio, ricevuto in dono da Rainaldo,
visconte di Beaune, ma di un grande cuore e di una fede sicura,
sostenuti dal desiderio, coltivato da anni, di una vita monastica
solitaria e povera, fedele alla tradizione degli antichi, rappresentata
dalla Regola di san Benedetto.
La preparazione della fondazione, San Roberto Ma
chi era il primo santo abate di Cîteaux e quali vicissitudini
lo avevano deciso, con i suoi compagni, a questo passo? Roberto
nacque verso il 1028 in un paesino della Champagne da nobili genitori
e, nella prima giovinezza, entrò nell'abbazia di Moutier-la-Celle
presso Troyes, dove, verso il 1053, divenne priore. Nel 1068 fu
eletto abate di Saint Michel de Tonnerre, poi, per ragioni ignote,
ritornò a Troyes e subito dopo fu eletto priore di Saint
Ayoul. Ma anche qui la sua permanenza fu breve: nel 1074 realizzò
il suo desiderio di vita eremitica ritirandosi nei boschi di Collan.
Presto altri eremiti si raggrupparono attorno a lui e il gruppo
divenne così numeroso da consigliare la fondazione di un
monastero, Molesme, nel 1075.
La sua esperienza, la fama della sua santità, il desiderio
di riformare la vita monastica imitando i Padri del deserto, attraverso
numerose vocazioni e molte donazioni dai nobili circostanti, gli
permisero di fondare priorati e abbazie dipendenti; si calcola
fossero una quarantina nel 1100. Un notevole successo, quindi,
ma ben presto il piccolo numero di eremiti fondatori si trovò
in minoranza e l'abbazia divenne in tutto simile alle tante esistenti
all'epoca. Non era decadenza, lo sviluppo lo attesta, ma le donazioni
comportavano privilegi per i nobili, che venivano almeno ogni
anno con la loro corte; vi erano servi e contadini; la povertà
e la solitudine erano scomparse, come la possibilità di
seguire fedelmente la Regola di san Benedetto. Ecco le
ragioni che spinsero i più fervorosi tra i monaci di Molesme
a fondare il Nuovo Monastero.
L'epoca storica.
Consideriamo brevemente l'epoca storica in cui si situa la
loro fondazione. Siamo all'apogeo di un rinnovamento, iniziato
nel X secolo e manifestato chiaramente nell'XI. La fine delle
grandi razzie degli Scandinavi dal nord, dai Saraceni dal Sud
e dagli Ungheresi dall'Est, rese possibile in Europa un grande
rinnovamento della società, sia sotto l'aspetto demografico,
economico, sociale, politico e culturale. La Chiesa partecipa
attivamente a questo sviluppo con la riforma Gregoriana,
promossa dal papa Gregorio VII (1073-1085): indipendenza della
Chiesa dal potere civile, ripresa del suo compito spirituale,
miglioramento del clero. Parte non piccola in questa riforma ebbe
il monachesimo, che già all'inizio del X secolo, con Cluny
specialmente, si libera dal dominio dei nobili, dipendendo formalmente
dal Papa, e conosce una crescita portentosa, in tutta Europa,
ininterrottamente per più di 200 anni, sotto la guida di
cinque santi abati. A Cluny grande importanza veniva data alla
liturgia, che occupava gran parte della giornata del monaco, con
conseguente riduzione al minimo del lavoro e della preghiera personale.
Voleva essere un preludio della Liturgia celeste e quindi
moltiplicava oro, argento, pietre preziose e sete per l'arredamento
dell'altare, delle chiese, delle processioni, dei pontificali.
Il governo era a imitazione della società feudale: da
Cluny dipendevano alcuni monasteri, che a loro volta avevano priorati,
in ordine gerarchico piramidale. Servitori e contadini supplivano
il lavoro dei monaci, che si riservavano la copia dei manoscritti,
cosa peraltro assai benemerita per la cultura. Erano anche molto
generosi con i poveri, sia abitualmente, sia soprattutto in occasione
delle ricorrenti carestie, durante le quali arrivavano fino a
vendere gli arredi della Chiesa per sovvenire alle necessità
degli indigenti.
Cluny non fu la sola riforma di quei secoli assai fecondi:
in Italia san Romualdo fonda Camaldoli nel 1012;  Giovanni
Gualberto fa nascere i Vallombrosani nel 1039; Pier
Damiani è eremita a Fonte Avellana. Nell'ovest della
Francia le nuove fondazioni e riforme furono numerose: tra le
più importanti, la congregazione di Savigny, l'ordine
di Grandmont, i monasteri doppi (monaci e monache) di Fontevrault,
i Certosini, fondati da san Bruno nel 1084. In più
le riforme canonicali dai Vittorini di Parigi e dei Premonstratensi.
Giovanni
Gualberto fa nascere i Vallombrosani nel 1039; Pier
Damiani è eremita a Fonte Avellana. Nell'ovest della
Francia le nuove fondazioni e riforme furono numerose: tra le
più importanti, la congregazione di Savigny, l'ordine
di Grandmont, i monasteri doppi (monaci e monache) di Fontevrault,
i Certosini, fondati da san Bruno nel 1084. In più
le riforme canonicali dai Vittorini di Parigi e dei Premonstratensi.
 Tutte o quasi queste riforme hanno la stessa
ispirazione: una vita più semplice e povera, più
solitaria e separata dal mondo, più vicina al grande modello
(in parte idealizzato) dei primi monaci. Nascono non in reazione
a un periodo di crisi, ma sulla spinta di una crescita spirituale
e materiale. È evidente che anche i
Tutte o quasi queste riforme hanno la stessa
ispirazione: una vita più semplice e povera, più
solitaria e separata dal mondo, più vicina al grande modello
(in parte idealizzato) dei primi monaci. Nascono non in reazione
a un periodo di crisi, ma sulla spinta di una crescita spirituale
e materiale. È evidente che anche i 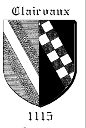 Cistercensi
si inseriscono in questo movimento e il loro grande successo è
dovuto all'aver saputo interpretare le esigenze, le aspirazioni
e la cultura della società di quel tempo, come vedremo
più in dettaglio. Cluny fu tuttavia la grande rappresentante
del monachesimo benedettino tradizionale, i cosiddetti monaci
neri, dal colore dell'abito, ai quali si contrapposero appunto
i cistercensi, in una fervida emulazione, non senza punte polemiche.
Furono chiamati monaci bianchi, dal colore del loro abito, fatto,
per povertà con la lana grezza delle pecore, senza alcuna
tintura.
Cistercensi
si inseriscono in questo movimento e il loro grande successo è
dovuto all'aver saputo interpretare le esigenze, le aspirazioni
e la cultura della società di quel tempo, come vedremo
più in dettaglio. Cluny fu tuttavia la grande rappresentante
del monachesimo benedettino tradizionale, i cosiddetti monaci
neri, dal colore dell'abito, ai quali si contrapposero appunto
i cistercensi, in una fervida emulazione, non senza punte polemiche.
Furono chiamati monaci bianchi, dal colore del loro abito, fatto,
per povertà con la lana grezza delle pecore, senza alcuna
tintura.
Sant'Alberico, il secondo Abate.
Possiamo riprendere la storia cistercense interrotta all'inizio
della fondazione, storia subito movimentata perché solo
un anno dopo la partenza dei 21 monaci fondatori, la situazione
a Molesme divenne critica: il successore di Roberto non aveva
un prestigio paragonabile al suo e la partenza dei monaci più
fervorosi fece sospettare gravi abusi, con la conseguente perdita
di stima e quindi di sovvenzioni dei nobili locali. L'unico rimedio
sembrò il ritorno di Roberto: ci si appellò al Papa,
che delegò il giudizio a un sinodo locale, il quale decise
di accogliere le richieste di Molesme. .
Vennero fissate delle norme di condotta e di vita che
cercavano di togliere dalle usanze monastiche del tempo tutto
ciò che era contrario alla Regola di san Benedetto. In
particolare si affermava la scelta della povertà e di un
luogo solitario per il monastero, l'obbligo del lavoro manuale
per i monaci, per provvedere al proprio sostentamento, rifiutando
le decime e i benefici ecclesiastici. Alberico fece appena in
tempo a consolidare la fondazione perché morì nel
gennaio del 1109, avendo come priore Stefano. che fu eletto subito
Abate.
Il terzo Abate: Santo Stefano Stefano Harding era di
famiglia nobile inglese ed entrò a Molesme al ritorno da
un viaggio a Roma, attratto dalla fama di questo monastero. Si
associò ben presto ai più fervorosi che desideravano
una vita più austera e fece parte dei ventun monaci che
fondarono Cîteaux. Ebbe subito la fiducia dei nobili vicini,
che con le loro donazioni accrebbero la proprietà del monastero,
proprio quando le vocazioni cominciavano a farsi numerose. Si
volle però premunire dal rischio di ritornare alla situazione
di Molesme e proibì ai donatori di venire a visitare il
monastero per trattenervisi con la loro corte a scopo devozionale.
Questa misura radicale, in contrasto con gli usi del tempo, non
gli alienò la simpatia e l'aiuto dei potenti. Stefano era
uno studioso: migliorò la liturgia facendo anche ricerche,
difficili per quei tempi, per avere degli inni autentici di sant'Ambrogio;
curò le ricerche accurate dei libri della Bibbia, anche
sui testi ebraici originali con l'aiuto di Rabbini eruditi e il
risultato fu una preziosa Bibbia che fece miniare dallo scriptorium
di Cîteaux e che è giunta fino a noi. Seguirono altri
lavori come la copia, sempre riccamente miniata, dei Moralia in
Job di san Gregorio Magno, opere che furono tra i capolavori dell'epoca.
 1. LA VITA COMUNE, IL LAVORO E LA SOLIDARIETÀ
La vita monastica, e in particolare quella cistercense, ha sempre
suscitato un grande interesse da parte di tutti, visto che la
figura del monaco non deve essere intesa solo come dedita alla
castità, alla povertà e all'obbedienza, ma anche
allo studio nel campo del sapere. Nella vita comune del monastero
i fondamentali valori erano la solidarietà, la carità
e l'amicizia. Fin dalle origini le prime norme che regolavano
le relazioni tra le abbazie erano raccolte sotto il titolo di
Carta di Carità. Il monastero cistercense era organizzato
secondo la regola di S. Benedetto. La forte scelta di vivere in
comune rendeva la loro vita simile a quella degli apostoli: essi,
sotto la guida della loro regola, condividevano tutto come nella
prima comunità cristiana descritta nel Nuovo Testamento.
I cistercensi non ammettevano la presenza di abbazie ricche e
di abbazie povere. La scelta del bene comune è la migliore
spiegazione della vita in comune: sentirsi parte di una stessa
chiesa e di uno stesso ordine spronava i monaci a vivere umilmente.
Sono queste le radici della condivisione e della solidarietà.
Esempio di ciò è Morimondo che dopo il terribile
saccheggio dei Pavesi del 1237, ciò che evitò la
fine della comunità fu la carità degli altri cenobi
cistercensi che curarono e ospitarono i feriti e i malati. Il
monachesimo cistercense, esplose nel XII secolo poiché
seppe coniugare l'ingegno e le capacità umane con la ricerca
dell'assoluto, fondando delle vere e proprie scuole. La vita dei
monaci era molto semplice e questo era sottolineato anche dagli
abiti che indossavano: umili e semplici, come anche il cibo: delicato
e non elaborato. Il monastero viene anche chiamato "palestra",
poiché lo spirito di carità tra i monaci era messo
a dura prova dai vari caratteri, dalle varie personalità,
dal loro impegno e dal diverso livello di conversazione, ma d'altro
canto era proprio il comune fine ultimo a sostenere la vita fraterna
fra i monaci. Risulta evidente che il cuore di un monastero cistercense
non è la sua organizzazione, ma questo impegno nel vivere
il comandamento evangelico della carità. Dal punto di vista
dell'attività intellettuale, a differenza dei loro contemporanei,
i monaci cistercensi, finito il lavoro di studio, si abbandonavano
alla preghiera e si servivano vicendevolmente alla mensa. E' interessante
quindi vedere che tra i monaci vigeva la comune "legge"
del lavoro inteso come solidarietà vicendevole. Un altro
aspetto di quest'Ordine è rappresentato dall'architettura
e dagli ambienti del monastero che risultano costruiti con strutture
analoghe e somiglianti.
1. LA VITA COMUNE, IL LAVORO E LA SOLIDARIETÀ
La vita monastica, e in particolare quella cistercense, ha sempre
suscitato un grande interesse da parte di tutti, visto che la
figura del monaco non deve essere intesa solo come dedita alla
castità, alla povertà e all'obbedienza, ma anche
allo studio nel campo del sapere. Nella vita comune del monastero
i fondamentali valori erano la solidarietà, la carità
e l'amicizia. Fin dalle origini le prime norme che regolavano
le relazioni tra le abbazie erano raccolte sotto il titolo di
Carta di Carità. Il monastero cistercense era organizzato
secondo la regola di S. Benedetto. La forte scelta di vivere in
comune rendeva la loro vita simile a quella degli apostoli: essi,
sotto la guida della loro regola, condividevano tutto come nella
prima comunità cristiana descritta nel Nuovo Testamento.
I cistercensi non ammettevano la presenza di abbazie ricche e
di abbazie povere. La scelta del bene comune è la migliore
spiegazione della vita in comune: sentirsi parte di una stessa
chiesa e di uno stesso ordine spronava i monaci a vivere umilmente.
Sono queste le radici della condivisione e della solidarietà.
Esempio di ciò è Morimondo che dopo il terribile
saccheggio dei Pavesi del 1237, ciò che evitò la
fine della comunità fu la carità degli altri cenobi
cistercensi che curarono e ospitarono i feriti e i malati. Il
monachesimo cistercense, esplose nel XII secolo poiché
seppe coniugare l'ingegno e le capacità umane con la ricerca
dell'assoluto, fondando delle vere e proprie scuole. La vita dei
monaci era molto semplice e questo era sottolineato anche dagli
abiti che indossavano: umili e semplici, come anche il cibo: delicato
e non elaborato. Il monastero viene anche chiamato "palestra",
poiché lo spirito di carità tra i monaci era messo
a dura prova dai vari caratteri, dalle varie personalità,
dal loro impegno e dal diverso livello di conversazione, ma d'altro
canto era proprio il comune fine ultimo a sostenere la vita fraterna
fra i monaci. Risulta evidente che il cuore di un monastero cistercense
non è la sua organizzazione, ma questo impegno nel vivere
il comandamento evangelico della carità. Dal punto di vista
dell'attività intellettuale, a differenza dei loro contemporanei,
i monaci cistercensi, finito il lavoro di studio, si abbandonavano
alla preghiera e si servivano vicendevolmente alla mensa. E' interessante
quindi vedere che tra i monaci vigeva la comune "legge"
del lavoro inteso come solidarietà vicendevole. Un altro
aspetto di quest'Ordine è rappresentato dall'architettura
e dagli ambienti del monastero che risultano costruiti con strutture
analoghe e somiglianti.
2. LA PREGHIERA BIBLICA FONTE DELLA VITA MONASTICA La Sacra
Scrittura è tutto per il monaco: in essa scopre il disegno
salvifico di Dio, attraverso essa comprende come accogliere nella
propria vita quotidiana questa salvezza e, leggendola e meditandola,
come interiorizzare la Rivelazione Divina. In altri termini la
Sacra Scrittura realizza il fine della vita del monaco che è
l'unione con Dio. Il metodo di assimilazione della Parola di Dio
avveniva con la Lectio Divina, cioè il metodo interiorizzazione
della Sacra Scrittura, mediante la sua memorizzazione. La lettura
continua della Sacra Scrittura da parte dei monaci non riguardava
settori precisi della vita ma riguardava tutto il cammino di fede
e di conversione che occorreva compiere ogni giorno. Lavoro manuale
e lavoro spirituale per il monaco vanno insieme: i servizi nel
monastero e l'impegno alla santità non sono disgiunti.
3. L'ARCHITETTURA PER LA LODE E PER IL SILENZIO Importante
è sottolineare che l'uniformità di stile e di planimetria
dell'architettura cistercense era l'espressione della ricerca
e dell'essenzialità e nasceva dal concetto dell'ideale
monastico. Per quanto riguarda la scelta del luogo si badava a
quelle aree solitarie, lontane da borghi o città e possibilmente
collocate nei boschi. Nella solitudine veniva rivissuta la spiritualità
del deserto, di cui i primi monaci cistercensi erano dei veri
amanti per potervi vivere la pace della contemplazione. Il deserto
è poi una scelta di povertà che nella vita comune
significa rinuncia e condivisione. Lode a Dio e silenzio erano
i due momenti per interiorizzare il mistero di Dio: Ora et Labora.
Se osserviamo le fattezze degli ambienti monastici notiamo che
tutti fanno pensare allo spirito di raccoglimento: è architettura
che è nata dalla contemplazione della parola di Dio e che,
con il clima di silenzio, aiutava la contemplazione dei monaci.
4. IL SENSO DEL LAVORO NEL MONASTERO Molto importante era
il lavoro manuale svolto con accuratezza e precisione dai monaci.
La Regola di S. Benedetto presenta diversi punti dove tutto ciò
emerge, per esempio quando si parla di turno settimanale, una
scena di vita famigliare, vissuta con lo stile della liturgia.
L'istituzione dei conversi fu anche risposta a un problema vocazionale
e dimostrò come l'ideale cistercense era condivisibile
non solo dalla nobiltà e dalla cavalleria, ma anche da
chi era di altre classi sociali. Questo nuovo apporto di forze
permetteva ai monaci di non venir meno sia al dovere della preghiera,
sia a quello del lavoro che da soli non avrebbero potuto affrontare.
Il monaco dunque sa di lavorare per vincere l'ozio e la necessità
della comunità, per la sua crescita, per contribuire alla
costruzione del cenobio o della chiesa abbaziale. Ognuno scopriva
il suo ruolo e la sua importanza all'interno della cittadella
monastica, poiché ognuno aveva un ruolo attivo di sostegno
nella comunità. Questo ci riconferma l'importanza di non
guardare il lavoro solo da punto di vista oggettivo, ma anche
dal punto di vista soggettivo e cioè come crescita della
persona nelle virtù e nell'umiltà.
5. I SERVIZI E IL LAVORO NELLA COMUNITÀ Il monastero
vive per l'operosità dei monaci che sotto la guida dell'Abate
e della Regola ordinano tutta la loro giornata ritmandola continuamente
con la preghiera e il lavoro; ognuno ha il suo ruolo, l'osservanza
della regola e l'obbedienza dell'abate sono le condizioni necessarie
per la ricerca del bene comune. Gli incarichi e gli uffici all'interno
del monastero dovevano coprire tutta una gamma di bisogni all'interno
della cittadella monastica. L'Abate, è la guida spirituale
e giuridica del monastero. Viene eletto dai monaci riuniti nel
Capitolo ed esercita per loro le funzioni di Padre e Maestro.
Il Priore, è l'aiutante dell'abate nel governo del monastero
I Decani, sono i monaci più anziani tra i più saggi
che formano il gruppo dei consiglieri dell'abate. Il Sacrestano,
oltre che curare la pulizia dei vasi sacri, deve preparare tutto
l'occorrente per la liturgia. I Copisti / Miniaturisti, sono i
monaci amanuensi addetti alla trascrizione di testi sacri, delle
opere dei Padri della Chiesa o di tutti i documenti necessari
ai monaci. Sono esperti anche nel preparare gli inchiostri. I
Pergamenari, preparano le pergamene. L'Ospitaliero, ha la responsabilità
della foresteria per accogliere i viaggiatori di passaggio. All'esterno
del monastero la principale attività era quella delle grange,
i centri agricoli cistercensi, che prevedevano svariate mansioni
nelle campagne.
6. L'ECONOMIA CISTERCENSE: L'ESPERIENZA IN EUROPA E A MORIMONDO
I monasteri cistercensi non si svilupparono solo in Italia , ma
anche in Europa. I monaci, grazie a questo ampio sviluppo territoriale
acquisirono una vasta competenza in diversi campi, dall'agricoltura
alla teologia. Ogni abbazia doveva essere autosufficiente in tutto,
per questo la produzione agricola doveva coprire il più
possibile del fabbisogno della comunità. A Morimondo, ad
esempio, le coltivazioni erano principalmente foraggio, miglio,
frumento e segale. Tutta questa industria cistercense fu possibile
grazie alla maestria dei conversi. Per ciò che riguarda
il lavoro a Morimondo occorre ricordare il concetto di servizio:
il lavoro comune era l'esercizio della solidarietà tra
i monaci. Grazie all'impegno di ogni singolo monaco e converso
l'abbazia è stata progressivamente edificata. Descrivendo
il lavoro agricolo a Morimondo è doveroso accennare all'uso
di irrigazione del prato a marcita; si deve a loro lo sfruttamento
"industriale" di questo sistema che non è altro
che l'irroramento di prati leggermente inclinati con acqua di
sorgente, la cui temperatura, essendo più alta di quella
esterna non permette gelate notturne. Tutta questa vita che abbiamo
descritto , è stata condotta con impegno dalla comunità
di Morimondo. Ogni monastero si differenzia per la presenza di
una figura di spicco quale l'abate, a Morimondo un'importante
figura fu certamente Pietro ( secondo abate di Morimondo), al
quale si deve l'estensione del territorio e il progressivo prestigio
assunto dall'abbazia. Molte furono in quel tempo le vocazioni
che decisero di consacrare la propria vita a Dio, divenendo prima
novizi e poi monaci o conversi a Morimondo.
I Cistercensi
FONDAZIONE E SVILUPPO
Fu l'abate Roberto insieme a pochi altri monaci a lasciare
l'abbazia di Molesme ed a fondare il nome di Citeaux che si rifaceva
alla Regola di San Benedetto.
ESPANSIONE E RIFORMA
L'ordine si diffuse con così sorprendente rapidità
che dovette essere diviso in una serie di congregazioni autonome:
ciò segnò la fine dell'ideale di unità dell'ordine.
Altri cambiamenti come, ad esempio, il coinvolgimento dei cistercensi
negli ordini militari ed il sistema commendatario portarono alla
rovina molte abbazie. Ci furono però anche diversi tentativi
di riforma tra i quali la costituzione della Stretta osservanza
da parte di Armand-Jean Le Bouthillier de Rancè che proponeva
un ritorno agli ideali ascetici ed in particolare al vegetarianesimo.
ELEMENTI COMUNI NELLE CHIESE CISTERCENSI :
A fondamento della cultura cistercense e delle sue decorazioni
c'è un elemento comune, anche se si manifesta in modi diversi
a seconda del luogo, delle dimensioni , dei materiali.
Si tratta dell'interiorizzazione che permette di creare un'atmosfera
armoniosa e favorevole per la preghiera, essenza della vita monastica.
Le vetrate colorate e i capitelli decorati erano banditi, perché
attiravano l'attenzione e distraevano la mente.
Per questo il colore della chiesa è o bianco sporco
o quello naturale della pietra.
Lo scopo dell'edificio non è quello di stupire lo spettatore
ma di far raggiungere al fedele la quiete interiore.
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA IN UN'ABBAZIA CISTERCENSE
Una delle innovazioni cistercensi maggiormente degne di nota
fu il Capitolo Generale : un corpo rappresentativo e centralizzato
di governo, che si riuniva annualmente per affrontare i problemi
ed attuare strategie comuni.
La Regola di S.Benedetto era il documento di basedella riforma
cistercense mentre l' horarium stabiliva l'unità di misura
della giornata monastica. Tutte le attività dovevano svolgersi
fra il sorgere ed il calar del sole.
L'attività principale dei monaci era l'opus Dei ma
a loro era richiesto anche di aiutare nel lavoro manuale e di
partecipare alla "lectio", la quale era la principale
forma di devozione cistercense al di fuori della Chiesa che consisteva
in una lenta assimilazione delle parole della Scrittura. Il silenzio
accompagnava ognuna di queste attività.
ABBIGLIAMENTO
Gli abiti dovevano essere umili e poco costosi, per le normali
attività quotidiane doveva bastare una tunica ed un paio
di scarpe.
MEMBRI DELLA COMUNITA' MONASTICA :
Il monastero medioevale era gestito in modo simile ad un feudo,
con tutte le responsabilità ed i doveri che ciò
comportava.
Colui che entrava in un monastero era solitamente adulto e
benestante però venivano accettati anche fratelli laici
detti "conversi".
All'interno della piramide ecclesiastica c'erano comunque l'abate,
il tesoriere, il priore, il sottopriore, il cellario, il sagrestano,
il cantore, il forestario ed il magister
IL MESSAGGIO
Oltre a svolgere una speciale funzione e ad avere una particolare
struttura, l'architettura della chiesa contiene anche un
messaggio che, semplice solo in apparenza, ha molti livelli.
Gli oltre otto secoli che ci separano dai primi edifici cistercensi,
con tutti i cambiamenti intervenuti nella società, nella
sensibilità e nella percezione del mondo, rendono ancora
più difficile la decifrazione di quel messaggio.
Gran parte di questo messaggio è veicolato attraverso
elementi di carattere non figurativo, come la scelta del luogo,
le dimensioni e i materiali, oltre a una simbolica tutta particolare.
Tale simbolica, naturalmente, era evidente alle persone viventi
ai tempi della costruzione di questi edifici, ma oggi il significato
è spesso oscuro oppure viene preso per qualcosa d'altro
perché è cambiato il quadro di riferimento. Se la
cattedrale (sede del vescovo) esprime un messaggio di potere,
di maestria tecnica e di padronanza tecnologica, a cui l'uomo
contemporaneo è assai sensibile, le chiese abbaziali, in
modo particolare quelle cistercensi, racchiudono tutt'altro messaggio.
Le chiese cistercensi venivano progettate e costruite come
luoghi di preghiera, di contemplazione e di celebrazione liturgica
per le monache e i monaci che le abitavano. Per comprendere pienamente
la chiesa monastica dobbiamo pensare alla vita condotta in un
monastero e alle ragioni che spingono un uomo o una donna a sceglierla.
San Benedetto nella Regola dice poco sulla chiesa, se non che
deve rispecchiare il concetto implicito nel suo nome (oratorium
: luogo di preghiera) e che, al termine dell'Opus Dei, bisogna
osservare il silenzio assoluto, affinchè quanti desiderano
trattenersi in chiesa per pregare possano farlo. Dietro il progetto
dell'architettura cistercense e delle sue decorazioni c'è
un elemento comune, anche se si manifesta in molti modi diversi
a seconda del luogo, delle dimensioni, del tipo di pietra utilizzata
e di altri aspetti. Si tratta della interiorizzazione, che permette
di creare un'atmosfera armoniosa e favorevole alla preghiera che,
come chiarisce San Benedetto, è l'essenza stessa della
vita monastica. Le finestre dalle vetrate colorate e i capitelli
con figurazioni narrative erano banditi nelle abbazie cistercensi
perché il colore e la narrazione attirano l'occhio e impegnano
la mente. Il colore attira l'attenzione, ha un effetto esteriorizzante,
e i colori saturi possono suscitare sentimenti di eccitazione,
esaltazione e persino frenesia.
A volte le chiese cistercensi sono di grandi dimensioni e possono
persino ricorrere agli ultimi ritrovati della tecnica delle costruzioni,
ma nella maggior parte dei casi sono deliberatamente spoglie:
il colore è il bianco sporco o quello naturale della pietra
e la decorazione è limitata al minimo. L'edificio non ha
come scopo lasciare senza fiato lo spettatore, ma fargli raggiungere
la quiete interiore.
Il "messaggio" della chiesa era un messaggio di semplicità,
armonia, tranquillità.
Il "processo di interiorizzazione" non è un
concetto architettonico benchè l'architettura venga
posta al servizio di quel processo. Sembra che costruendo una
chiesa secondo principi geometrici elementari, limitando al minimo
la decorazione ed evitando di ricorrere agli elementi figurativi
e al colore, l'edificio stesso della chiesa offra un messaggio
di semplicità e tranquillità che si propone di essere
assorbito nello stile di vita del monaco o della monaca che lì
prega.
I CONVERSI
L'ultimo quarto del chiostro, o ala occidentale, era generalmente
il settore dei conversi. I conversi, o fratelli laici, erano dei
religiosi laici che avevano pronunciato i voti monastici, ma la
cui vita monastica era più orientata verso il lavoro manuale
che verso la celebrazione della liturgia.
L'istituzione della confraternita laica non era un'invenzione
cistercense, sebbene i Cistercensi ne abbiano fatto un uso maggiore
di qualsiasi altro Ordine. Essa in parte ebbe inizio con Benedetto
d'Aniane, l'abate austero e ascetico che era stato scelto da Ludovico
il Pio per dirigere la riforma delle case monastiche nell'Impero
carolingio. La sua interpretazione della Regola di San Benedetto
consisteva nella richiesta che i monaci trascorressero più
tempo in chiesa che nei campi all'aperto. Inoltre fra i monaci
istruiti si diffuse l'abitudine di dedicare sempre più
tempo allo studio. D'altra parte a partire dal IX secolo, le dimensioni
delle proprietà monastiche registrarono un notevole aumento
e inevitabilmente il bisogno di gestire queste estensioni sempre
più vaste, urtò con le esigenze della liturgia,
della cultura e della vita sacerdotale. Per questo motivo, la
soluzione adottata da Cluny e dalla maggior parte degli altri
monasteri del tempo, consisteva nell'amministrare le estese proprietà
monastiche affidando il lavoro agricolo e l'allevamento ai contadini
del posto e lasciando i monaci sacerdoti liberi di occuparsi degli
impegni "sacerdotali". Ma questa soluzione poneva un
altro problema. Ovviamente i contadini erano laici e talvolta
la loro presenza nelle terre monastiche o nei dintorni introduceva
nella vita claustrale un elemento di mondanità che sarebbe
stato meglio evitare. D'altronde non mancavano membri del laicato
che desideravano imitare la vita monastica, pur senza abbracciarla
completamente, ed era proprio il desiderio di accettare il giogo
del Vangelo che distingueva il CONVERSUS dal comune lavoratore
alle dipendenze dell'abbazia.
Resta incerto il momento in cui questa istituzione venne introdotta
nell'Ordine ed è impossibile indicare un anno in particolare.
Sembra comunque probabile che inizialmente la necessità
di arruolare fratelli laici o conversi si sia manifestata con
l'aumento delle proprietà cistercensi nei primi anni in
cui era abate Stefano Harding i conversi una volta ammessi non
dovevano essere trattati come i lavoratori alle dipendenze dell'abbazia
o come cittadini di seconda categoria, bensì come compartecipi
alla vita religiosa il cui status esigeva rispetto esattamente
come quello dei monaci.
Ai conversi si richiedeva, come per i monaci, un periodo di
prova di un anno. Una volta ammessi all'Ordine e pronunciati i
voti nessun converso poteva diventare monaco. In origine l'età
minima per essere ricevuti come conversi era 15 anni, ma nella
seconda metà del XII secolo fu portata a 18.
L'abito dei conversi era diverso da quello dei monaci come
la loro collocazione sociale, la loro cultura, la loro istruzione
e il loro stile di vita.
Fra i conversi non mancavano persone nobili o colte, ma questi
casi non erano la regola. Le occupazioni dei conversi comprendevano
qualsiasi cosa riguardasse la conduzione pratica quotidiana delle
proprietà monastiche. Nei loro compiti potevano essere
aiutati dai familiares o "famigli", ossia uomini che
vivevano a stretto contatto con loro e che sbrigavano più
o meno lo stesso lavoro, ma che non avevano la medesima professione
religiosa né gli stessi obblighi. Probabilmente i familiares
erano assunti in numero consistente, quello che è certo
è che, con la riduzione del numero dei conversi nel XIII
secolo, i familiares divennero sempre più importanti, tanto
che alla fine del secolo erano così numerosi che causarono
non pochi problemi disciplinari; perciò nel 1293, il Capitolo
Generale, abolì l'istituzione dei familiares, anche se
questi sopravvissero ben oltre la fine del Medioevo.
I conversi dei monasteri femminili cistercensi ricoprivano
dei compiti simili, ricevevano l'addestramento iniziale in un'abbazia
maschile, ma facevano la loro professione alla badessa; vivevano
al di fuori della clausura delle monache, ma in certe occasioni
si univano alle monache come parte della famiglia monastica. Anche
se erano numerose le mansioni dentro e attorno al chiostro che
inevitabilmente avvicinavano monaci e conversi, per lo meno fisicamente,
in linea di principio essi costituivano due gruppi separati e
le loro vite seguivano strade diverse.
Ad eccezione delle domeniche e delle festività religiose,
i conversi non partecipavano agli uffici divini e invece recitavano
in particolari momenti trenta Pater noster e Gloria, con un Kyrie
eleison dopo il ventesimo, ovunque stessero lavorando.
I motivi che spingevano questi uomini a entrare in un monastero
erano certamente i più vari: alcuni cercavano una vita
santa di lavoro nella preghiera e di preghiera nel lavoro, molti
però avevano interessi più mondani e cercavano sicurezza,
un tetto e cibo regolare.
Alla fine del XIII secolo molti fattori di incertezza degli
anni precedenti erano scomparsi e ora la sicurezza poteva essere
trovata in luoghi diversi dai monasteri cistercensi. Le vocazioni
dei conversi iniziarono quindi a declinare e le abbazie, che dipendevano
ancora da loro per la propria autosufficienza economica, si videro
obbligate a giungere a dei compromessi. Tuttavia man mano che
il livello dei conversi si abbassava e che il rapporto tra monaci
e conversi diventava sempre più simile a quello fra padrone
e servo, crebbero i casi di insubordinazione e ribellione da parte
dei conversi.
Il Capitolo Generale nel 1237 permise allora ai monasteri di
avere non più di otto conversi e di assumere dei domestici
laici per la cucina, e per l'amministrazione agricola si formò
una classe di piccoli coltivatori più o meno fidata che
viveva stabilmente sui terreni abbaziali, per la coltivazione
dei quali pagava un affitto regolare.
Nell'Europa Occidentale, comunque, la riduzione divenne critica
solo con le devastazioni della Peste Nera nel 1347-1350.
Dalla fine del XIV secolo in poi l'istituzione della confraternita
laica non svolse più un ruolo rilevante nell'economia monastica
cistercense, solo nel XIX secolo il numero dei conversi riprese
ad aumentare.
 La fondazione di Cîteaux Nove secoli
fa, nel 1098, il giorno 21 marzo, inizio della Primavera, festa
di san Benedetto e, in quell'anno anche Domenica delle Palme,
ventun monaci lasciarono il monastero di Molesme per fondare,
nella Borgogna francese, 20 Km. a Sud di Digione, un nuovo insediamento
monastico, che fu chiamato "Nuovo Monastero". A capo
dei 21 monaci c'era proprio l'abate di Molesme, Roberto, che aveva
avuto in precedenza l'approvazione del Legato del Papa, Ugo, Arcivescovo
di Lione. Più tardi il "nuovo monastero" prese
il nome di Cîteaux, dal nome della località, Cistercium,
in latino. Ecco, in poche parole, l'origine dei Cistercensi, che
tanto sviluppo dovevano avere nei secoli seguenti. Origini umili
e difficili, di uomini che disponevano di pochissimi mezzi, di
un terreno incolto e selvaggio, ricevuto in dono da Rainaldo,
visconte di Beaune, ma di un grande cuore e di una fede sicura,
sostenuti dal desiderio, coltivato da anni, di una vita monastica
solitaria e povera, fedele alla tradizione degli antichi, rappresentata
dalla Regola di san Benedetto.
La fondazione di Cîteaux Nove secoli
fa, nel 1098, il giorno 21 marzo, inizio della Primavera, festa
di san Benedetto e, in quell'anno anche Domenica delle Palme,
ventun monaci lasciarono il monastero di Molesme per fondare,
nella Borgogna francese, 20 Km. a Sud di Digione, un nuovo insediamento
monastico, che fu chiamato "Nuovo Monastero". A capo
dei 21 monaci c'era proprio l'abate di Molesme, Roberto, che aveva
avuto in precedenza l'approvazione del Legato del Papa, Ugo, Arcivescovo
di Lione. Più tardi il "nuovo monastero" prese
il nome di Cîteaux, dal nome della località, Cistercium,
in latino. Ecco, in poche parole, l'origine dei Cistercensi, che
tanto sviluppo dovevano avere nei secoli seguenti. Origini umili
e difficili, di uomini che disponevano di pochissimi mezzi, di
un terreno incolto e selvaggio, ricevuto in dono da Rainaldo,
visconte di Beaune, ma di un grande cuore e di una fede sicura,
sostenuti dal desiderio, coltivato da anni, di una vita monastica
solitaria e povera, fedele alla tradizione degli antichi, rappresentata
dalla Regola di san Benedetto.  Giovanni
Gualberto fa nascere i Vallombrosani nel 1039; Pier
Damiani è eremita a Fonte Avellana. Nell'ovest della
Francia le nuove fondazioni e riforme furono numerose: tra le
più importanti, la congregazione di Savigny, l'ordine
di Grandmont, i monasteri doppi (monaci e monache) di Fontevrault,
i Certosini, fondati da san Bruno nel 1084. In più
le riforme canonicali dai Vittorini di Parigi e dei Premonstratensi.
Giovanni
Gualberto fa nascere i Vallombrosani nel 1039; Pier
Damiani è eremita a Fonte Avellana. Nell'ovest della
Francia le nuove fondazioni e riforme furono numerose: tra le
più importanti, la congregazione di Savigny, l'ordine
di Grandmont, i monasteri doppi (monaci e monache) di Fontevrault,
i Certosini, fondati da san Bruno nel 1084. In più
le riforme canonicali dai Vittorini di Parigi e dei Premonstratensi.
 Tutte o quasi queste riforme hanno la stessa
ispirazione: una vita più semplice e povera, più
solitaria e separata dal mondo, più vicina al grande modello
(in parte idealizzato) dei primi monaci. Nascono non in reazione
a un periodo di crisi, ma sulla spinta di una crescita spirituale
e materiale. È evidente che anche i
Tutte o quasi queste riforme hanno la stessa
ispirazione: una vita più semplice e povera, più
solitaria e separata dal mondo, più vicina al grande modello
(in parte idealizzato) dei primi monaci. Nascono non in reazione
a un periodo di crisi, ma sulla spinta di una crescita spirituale
e materiale. È evidente che anche i 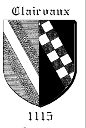 Cistercensi
si inseriscono in questo movimento e il loro grande successo è
dovuto all'aver saputo interpretare le esigenze, le aspirazioni
e la cultura della società di quel tempo, come vedremo
più in dettaglio. Cluny fu tuttavia la grande rappresentante
del monachesimo benedettino tradizionale, i cosiddetti monaci
neri, dal colore dell'abito, ai quali si contrapposero appunto
i cistercensi, in una fervida emulazione, non senza punte polemiche.
Furono chiamati monaci bianchi, dal colore del loro abito, fatto,
per povertà con la lana grezza delle pecore, senza alcuna
tintura.
Cistercensi
si inseriscono in questo movimento e il loro grande successo è
dovuto all'aver saputo interpretare le esigenze, le aspirazioni
e la cultura della società di quel tempo, come vedremo
più in dettaglio. Cluny fu tuttavia la grande rappresentante
del monachesimo benedettino tradizionale, i cosiddetti monaci
neri, dal colore dell'abito, ai quali si contrapposero appunto
i cistercensi, in una fervida emulazione, non senza punte polemiche.
Furono chiamati monaci bianchi, dal colore del loro abito, fatto,
per povertà con la lana grezza delle pecore, senza alcuna
tintura.  1. LA VITA COMUNE, IL LAVORO E LA SOLIDARIETÀ
La vita monastica, e in particolare quella cistercense, ha sempre
suscitato un grande interesse da parte di tutti, visto che la
figura del monaco non deve essere intesa solo come dedita alla
castità, alla povertà e all'obbedienza, ma anche
allo studio nel campo del sapere. Nella vita comune del monastero
i fondamentali valori erano la solidarietà, la carità
e l'amicizia. Fin dalle origini le prime norme che regolavano
le relazioni tra le abbazie erano raccolte sotto il titolo di
Carta di Carità. Il monastero cistercense era organizzato
secondo la regola di S. Benedetto. La forte scelta di vivere in
comune rendeva la loro vita simile a quella degli apostoli: essi,
sotto la guida della loro regola, condividevano tutto come nella
prima comunità cristiana descritta nel Nuovo Testamento.
I cistercensi non ammettevano la presenza di abbazie ricche e
di abbazie povere. La scelta del bene comune è la migliore
spiegazione della vita in comune: sentirsi parte di una stessa
chiesa e di uno stesso ordine spronava i monaci a vivere umilmente.
Sono queste le radici della condivisione e della solidarietà.
Esempio di ciò è Morimondo che dopo il terribile
saccheggio dei Pavesi del 1237, ciò che evitò la
fine della comunità fu la carità degli altri cenobi
cistercensi che curarono e ospitarono i feriti e i malati. Il
monachesimo cistercense, esplose nel XII secolo poiché
seppe coniugare l'ingegno e le capacità umane con la ricerca
dell'assoluto, fondando delle vere e proprie scuole. La vita dei
monaci era molto semplice e questo era sottolineato anche dagli
abiti che indossavano: umili e semplici, come anche il cibo: delicato
e non elaborato. Il monastero viene anche chiamato "palestra",
poiché lo spirito di carità tra i monaci era messo
a dura prova dai vari caratteri, dalle varie personalità,
dal loro impegno e dal diverso livello di conversazione, ma d'altro
canto era proprio il comune fine ultimo a sostenere la vita fraterna
fra i monaci. Risulta evidente che il cuore di un monastero cistercense
non è la sua organizzazione, ma questo impegno nel vivere
il comandamento evangelico della carità. Dal punto di vista
dell'attività intellettuale, a differenza dei loro contemporanei,
i monaci cistercensi, finito il lavoro di studio, si abbandonavano
alla preghiera e si servivano vicendevolmente alla mensa. E' interessante
quindi vedere che tra i monaci vigeva la comune "legge"
del lavoro inteso come solidarietà vicendevole. Un altro
aspetto di quest'Ordine è rappresentato dall'architettura
e dagli ambienti del monastero che risultano costruiti con strutture
analoghe e somiglianti.
1. LA VITA COMUNE, IL LAVORO E LA SOLIDARIETÀ
La vita monastica, e in particolare quella cistercense, ha sempre
suscitato un grande interesse da parte di tutti, visto che la
figura del monaco non deve essere intesa solo come dedita alla
castità, alla povertà e all'obbedienza, ma anche
allo studio nel campo del sapere. Nella vita comune del monastero
i fondamentali valori erano la solidarietà, la carità
e l'amicizia. Fin dalle origini le prime norme che regolavano
le relazioni tra le abbazie erano raccolte sotto il titolo di
Carta di Carità. Il monastero cistercense era organizzato
secondo la regola di S. Benedetto. La forte scelta di vivere in
comune rendeva la loro vita simile a quella degli apostoli: essi,
sotto la guida della loro regola, condividevano tutto come nella
prima comunità cristiana descritta nel Nuovo Testamento.
I cistercensi non ammettevano la presenza di abbazie ricche e
di abbazie povere. La scelta del bene comune è la migliore
spiegazione della vita in comune: sentirsi parte di una stessa
chiesa e di uno stesso ordine spronava i monaci a vivere umilmente.
Sono queste le radici della condivisione e della solidarietà.
Esempio di ciò è Morimondo che dopo il terribile
saccheggio dei Pavesi del 1237, ciò che evitò la
fine della comunità fu la carità degli altri cenobi
cistercensi che curarono e ospitarono i feriti e i malati. Il
monachesimo cistercense, esplose nel XII secolo poiché
seppe coniugare l'ingegno e le capacità umane con la ricerca
dell'assoluto, fondando delle vere e proprie scuole. La vita dei
monaci era molto semplice e questo era sottolineato anche dagli
abiti che indossavano: umili e semplici, come anche il cibo: delicato
e non elaborato. Il monastero viene anche chiamato "palestra",
poiché lo spirito di carità tra i monaci era messo
a dura prova dai vari caratteri, dalle varie personalità,
dal loro impegno e dal diverso livello di conversazione, ma d'altro
canto era proprio il comune fine ultimo a sostenere la vita fraterna
fra i monaci. Risulta evidente che il cuore di un monastero cistercense
non è la sua organizzazione, ma questo impegno nel vivere
il comandamento evangelico della carità. Dal punto di vista
dell'attività intellettuale, a differenza dei loro contemporanei,
i monaci cistercensi, finito il lavoro di studio, si abbandonavano
alla preghiera e si servivano vicendevolmente alla mensa. E' interessante
quindi vedere che tra i monaci vigeva la comune "legge"
del lavoro inteso come solidarietà vicendevole. Un altro
aspetto di quest'Ordine è rappresentato dall'architettura
e dagli ambienti del monastero che risultano costruiti con strutture
analoghe e somiglianti.