Il viaggio via
mare
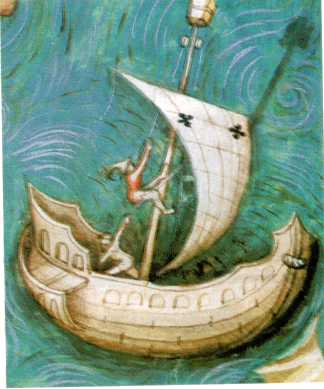 Nel Medioevo un viaggio via
mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano
stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni
dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,
a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini
più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio
spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere
due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,
ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano
riempiti fino all'inverosimile.
Nel Medioevo un viaggio via
mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano
stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni
dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,
a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini
più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio
spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere
due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,
ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano
riempiti fino all'inverosimile.
Ai pellegrini veniva consigliato di portarsi qualcosa su
cui sdraiarsi e indumenti caldi, oltre a provviste (formaggio,
salsicce, carne salata, biscotti bianchi, pani di zucchero e dolciumi)
per integrare la magra dieta fornita dalla nave, e a qualche spezia
forte per curarsi indigestioni e mal di mare. Dopo la fame e l'insonnia,
la noia era il principale problema dei passeggeri. Per occupare
il tempo alcuni passavano la giornata a bere, altri a giocare
a carte o ai dadi, anche gli scacchi erano un gioco molto comune.
Sullo sfondo si sentiva da mattina a sera cantare in coro. Un
piccolo gruppo di pellegrini contemplativi si riuniva in un angolo
a scrivere o a pregare. Altri dormivano giorno e notte. Molti
scrivevano il diario di viaggio. L'unico passatempo organizzato
erano le prediche. La tediosa calma di un lungo viaggio in mare
era di tanto in tanto disturbata dalla comparsa dei pirati.
La legge del mare imponeva a tutti i passeggeri di partecipare
alla difesa della nave e i pellegrini, sebbene fossero esenti
da quest'obbligo a causa dell'ispirazione religiosa del loro viaggio,
combattevano di solito con lo stesso coraggio degli altri. Nonostante
il peggiorare dei rapporti tra Islam ed Occidente con un conseguente
aumento di tasse e pedaggi, i pellegrini continuavano ad andare
in Terra Santa, soprattutto grazie all'iniziativa dei Veneziani.
Le severe norme imposte dalla Serenissima infatti garantivano
un elevato grado di sicurezza del viaggio ed una moralità
commerciale che altri porti non offrivano (gli armatori genovesi
e pisani erano sospettati di vendere i passeggeri come schiavi
nei porti arabi).
Vantaggi che offriva il porto veneto: - essendoci molte
navi che salpavano l'attesa per imbarcarsi era di pochi giorni
- il porto, per la sua posizione geografica, era al sicuro dagli
attacchi dei pirati - i Veneziani scortavano i pellegrini per
gran parte del percorso - la moneta veneziana era tra le più
stabili in tutto l'Occidente, inoltre era l'unica ad essere legale
anche nei territori arabi - i Veneziani erano una buona compagnia.
Le galere autorizzate dalla repubblica partivano per Giaffa
ogni anno, subito dopo l'Ascensione, e ritornavano in autunno.
Quando le richieste erano numerose partivano da Venezia due flotte,
una in marzo e l'altra in settembre. La quota pagata comprendeva
vitto e alloggio per tutto il viaggio, compreso il soggiorno in
Terra Santa; l'armatore, che di solito era anche il capitano della
nave, pagava tutte le tasse e i pedaggi, le spese per gli asini
e i cavalli da soma, le visite guidate di Gerusalemme e le escursioni
speciali al Giordano. La popolarità di questi viaggi era
totalmente dovuta all'alta reputazione di cui godevano gli armatori
veneziani.
La repubblica veneta cominciò ad autorizzare e regolare
il traffico dei pellegrini a partire dagli inizi del XIII secolo
(numero massimo di pellegrini per ogni nave e data di partenza).
Vi era un lungo contratto Giaffa-Venezia nel quale erano stabiliti
i diritti e i doveri del pellegrino. All'inizio del XV secolo
però le controversie tra i due porti erano diventate tali
e tante che nel 1437 la repubblica veneta aveva preso l'estrema
misura di sospendere i pellegrinaggi annuali via mare. Questi
furono ripresi nel 1440 su basi diverse, ma con un progressivo
declino, finché l'interesse per i luoghi santi svanì,
e gli armatori non furono più in grado di offrire viaggi
a buon mercato.
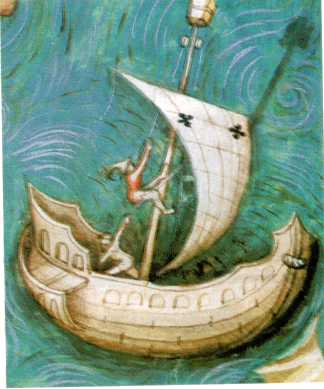 Nel Medioevo un viaggio via
mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano
stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni
dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,
a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini
più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio
spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere
due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,
ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano
riempiti fino all'inverosimile.
Nel Medioevo un viaggio via
mare era un'esperienza tutt'altro che agevole. I pellegrini venivano
stipati come chicchi di grano su piccole ed instabili imbarcazioni
dove, per sei settimane, dovevano restare a cibo e acqua conservati,
a noia, malattie e a scomodità di ogni genere. I pellegrini
più abbienti potevano alleviare le durezze del viaggio
spendendo qualcosa in più. A Venezia si potevano prendere
due tipi di imbarcazioni: grandi galere a remi, comode e sicure,
ma molto costose; piccoli vascelli per uso dei poveri, che venivano
riempiti fino all'inverosimile.