ex internet Luciano Santella[2]
La Liguria
"Tu, homo chi vai per via san e zovem e fresco (e forte) non andar per vie torte como nave senza guia". [Anonimo genovese]
La Lunigiana, terra di confine della Toscana, incuneata tra l'Emilia e la propaggine meridionale della Liguria, nella provincia della Spezia, deve il suo nome alla città di Luni. La via Francigena si inoltra in questa verde terra dove si estende il bacino del fiume Magra. Questo forma in alcuni tratti ampie anse fiancheggiate da una fitta vegetazione, e raccoglie le acque di torrenti e ruscelli, creando cascate e grotte di straordinaria bellezza. Alla foce del fiume sorge Luni, di origine etrusca, colonia romana nel 177 a.C.. Città fiorente per le vicine cave di marmo apuano esportato in tutto il mondo romano e per i tronchi d'albero delle foreste appenniniche che vengono fatti scendere sul fiume, è anche importante scalo marittimo e nodo rilevante della viabilità antica. Infatti la Via Aurelia la collega con Roma, con la Liguria e con la Gallia Cisalpina. Nell'VIII secolo inizia la decadenza di Luni, antagonista perdente di Lucca. Nel corso dei secoli IX e X fanno sentire i propri effetti l'interramento del porto dovuto alle alluvioni del Magra, le lotte feudali e la malaria. Il progressivo spopolamento e la traslazione della sede vescovile a Sarzana (1204) decretano la morte di Luni, e dal secolo XIII in poi anche la direttrice del pellegrinaggio comincia ad allontanarsi dalle sue rovine. Luni (Liguria). Particolare del decumano massimo, tratto cittadino dell'Aurelia[3].
In tutti i centri ove il cammino per Roma diveniva pressochè
unico, avendo accolto le ramificazioni provenienti dalle varie regioni
europee si ripeteva il fenomeno della presenza di ragguardevoli strutture
ricettive, come i casi di Piacenza, San Gimignano, Siena e Viterbo.
A Lucca, città che costituiva un punto di passaggio
obbligatorio e quasi la "porta di Roma" per tutti coloro che scendevano
dall'Europa centrosettentrionale, erano venerati ben quattro santi pellegrini:
Riccardo, un leggendario re degli anglosassoni, Davino, Avertano e Romeo,
compagno di pellegrinaggio di sant'Avertano, che cambiò il suo vero
nome, Enrico, in quello di Romeo, sinonimo di pellegrino diretto a Roma.
La grande fioritura e l'ampliamento dei traffici commerciali del
Duecento favorirono l'affermarsi di itinerari alternativi che spesso si
sostituirono, almeno in parte a quello della Francigena. E' il caso, per
esempio, del ruolo svolto dalla città di Firenze, che sposterà
l'asse delle comunicazioni con Roma dalla valle dell'Elsa a favore
del proprio territorio.
|
The middle part |
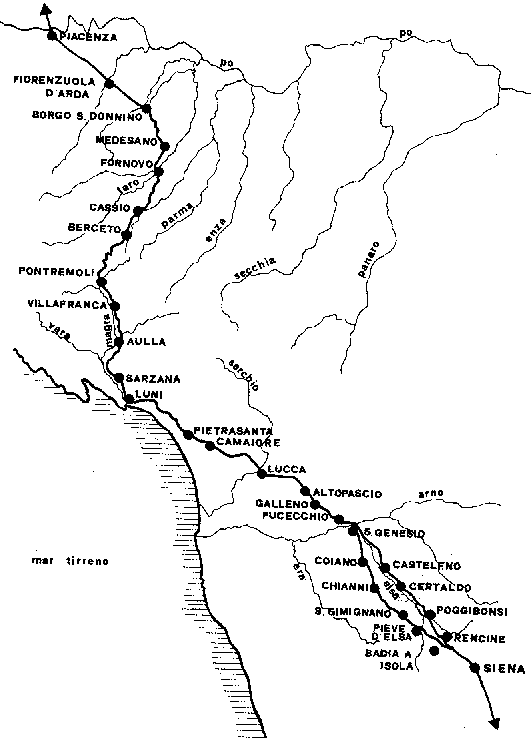
La Via Francigena o Romea, dopo aver superato il Passo della Cisa conosciuto nel Medioevo come Monte Bardone, toccava Luni, città di origine romana che ebbe un famoso porto legato prevalentemente al commercio dei marmi: Massa, ai piedi delle imponenti pareti Apuane lambite dal Mar Tirreno.
Entrava poi nel territorio Lucchese procedendo verso Sud dopo aver attraversato Porta Beltrame passo obbligato tra la collina e la palude.
Arrivava a Sala, borgo fortificato posto al di sopra dell'odiena Pietrasanta, a ridosso della quale si trovava l'ospedale di Munt Chevrol annesso al monastero femminile di San Salvatore.
Di lì a poco si incontrava con la strada proveniente dall'entroterra che collegava i territori di Modena e della Garfagnana. Il pellegrino poteva trovare ristoro lungo il percorso montuoso presso gli antichi ospedali di San Pellegrino in Alpe sull'Appennino, e di Volasco sulle Alpi Apuane. Superata poi la Pieve dei Santi Giovanni e felicita, il pellegrino poteva immettersi sulla Via Romea.
Riprendendo il cammino lungo la via maestra si incontrava la città di Camaiore, l'antica Campus Maior menzionata anche da Sigerico, vescovo di Canterbury. Grazie al diario del suo viaggio, intrapreso nel 990, è stato possibile ricostruire il percorso della Francigena.
La strada, dominata dall'alto da alcune fortezze, si inerpicava sulle colline di Monte Magno, dove l'accoglienza era offerta dall'ospedale di San Michele.
Da Monte Magno la Francigena discendeva la valle della Freddana fino ad incontrare ll'ospedale di San Martino presso Valpomaro.
Dopo queste località possiamo ricostruire due tracciati per
raggiungere Lucca, forse utilizzati in epoche diverse. Il primo, superando
il Passo delle Gavine, discendeva per la valle
della Contèsora passando innanzi all'ospedale di San Michele
di Contèsora. Una lapide, rimasta sulla facciata della chiesina,
conserva l'iscrizione con il nome del fondatore Ugolino e la data di fondazione:
1175.
Giungeva nel territorio di San Macario in Piano dove tappa di rilievo era l'ospedale di San Jacopo delle Beltraie che serba tutt'oggi la primitiva struttura romantica adibita ora ad uso civile, per arrivare quindi all'attuale Ponte San Pietro. Qui, prima della costruzione del Ponte, il pellegrino poteva attraversare il Serchio in barca, come è testimoniato dal toponimo di Nave, località sulla sponda sinistra del fiume.
Da Monte Magno si poteva prendere una "diversione" o "diverticolo" (in gergo meievale) passando per Pieve Elici verso Massarosa e Massaciuccoli: dopo aver superato il sistema collinare del Quièsa ci si immetteva su un'ampia via verso Lucca, passando ai piedi del Castello di Nozzano e attraversando la Pievania di Arlianoper raggiungere l'attuale Ponte San Pietro.
Il secondo itinerario prinzipale proseguiva lungo la valle della freddana e quindi, superando il passo tra le colline di Sant'Alessio e San Martino in Vignale, giungeva a Lucca.
La città di Lucca, già capitale della Tuscia in periodo longobardo, a partire dal X secolo, proprio per la sua posizione sulla via Francigena, ebbe rispetto ad altre città una precoce ripresa economica come avvenne nel caso di Siena.
La strada Romea determinò tra l'altro una notevole influenza anche sulle tradizioni religiose della città, in quanto diffuse il culto del Volto Santo, favorendo i frequenti spostamenti dei mercanti lucchesi nelle varie località europee.
L'elevato numero di ospedali sia nel centro che nel suburbio, testimonia il grande afflusso di devoti che giungevano a Lucca, tappa d'obbligo per i pellegrinaggi verso Roma e Gerusalemme oppure, in senso contrario, verso Santiago di Compostella.
Proseguendo verso est, il cammino dei pellegrini toccava le località di San Vito e Lunata. Nella vicina località di Lammari, sono visibili le chiese dedicate a due santi pellegrini per tradizione: la chiesa di San Jacopo e quella di San Cristoforo.
Quindi la Via Francigena proseguiva sulla pianura dominata dalle fortezze di Porcari e di Montecarlo. Attraversava Rughi e la Forcri di Sigerico, l'odierna Porcari, per giungere ad Altopascio, dimora dell'ordine ospitaliero dei Cavalieri del Tau che operavano nel famoso ospedale di San Jacopo.
Poco lontano si ergeva l'antica e potente Abbazia di Pozzeveri con l'annesso ospedale di San Pietro.
Dopo Altopascio la strada si inoltrava per le Cerbaie dove i resti dell'antica via sono ancora evidenti, e proseguiva in direzione di San Miniato e Siena.
La fine del percorso lucchese era segnata dai rintocchi della "Smarrita", la nota campana che orientava i viandanti fra le insidie del cammino nel padule di Fucecchio.
La lunga fatica del pellegrino era finalmente ricompensata dall'ingresso in Roma, città eterna, luogo del martirio dei santi Pietro e Paolo.
Se "tutte le strade portano a Roma" secondo l'antico detto popolare,
la Via Francigena fra tutte, è indubbiamente la più affascinante:
è la strada che porta in sè lo spirito di una ricerca di
una unità nelle diversità che contribuisce a costruire l'identità
culturale dell'Europa di oggi.
---------------------- * * *
La direttrice Bologna-Firenze-Siena-Roma negli ultimi secoli
del Medioevo, continuerà ad essere denominata "romea" o strada regia
romana, segno che la destinazione finale, Roma, era divenuta prioritaria
rispetto a quella settentrionale. Ma la Francigena o Romea non era solo
la strada dei pellegrini romei: nei numerosi ospizi ed ospedali sorti lungo
il cammino, transitavano anche coloro che si dirigevano verso la Terra
Santa e Santiago di Compostela. Infatti data questa possibilità
di unire con un solo itinerario più pellegrinaggi, raramente chi
si recava al Santo Sepolcro provenendo dal mondo scandinavo o dall'Europa
centrale evitava Roma transitando per la litoranea adriatica. Oltre alle
tre mete principali, i pellegrini avevano la possibilità di fare
tutta una serie di pellegrinaggi minori, che a volte si trovavano sullo
stesso itinerario o che, in altri casi, potevano essere raggiunti con brevi
deviazioni.