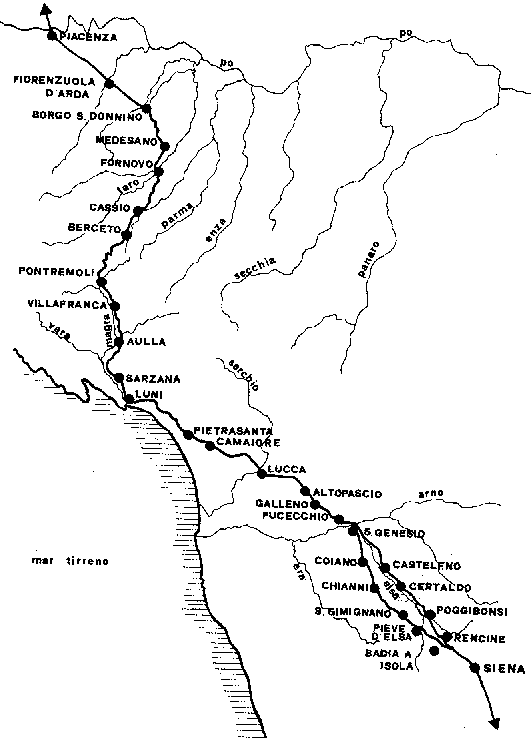
Lungo i percorsi padani troviamo un rarefarsi dei luoghi di tappa
enumerati dalle fonti itinerarie; questo per la Pianura Padana, che con
il suo tipico paesaggio piano solcato dal Po e dai suoi affluenti e con
le sue vie lineari e spedite, determinava una maggiore celerità'
riguardo ai suoi tempi di percorrenza. La principale arteria per i collegamenti
tra l'Italia e il mondo d'oltralpe era la Via Francigena. Le sue origini
risalgono ai Longobardi che furono costretti a cercare Un passaggio nella
dorsale appenninica lontano dalle coste (controllate dai Bizantini).
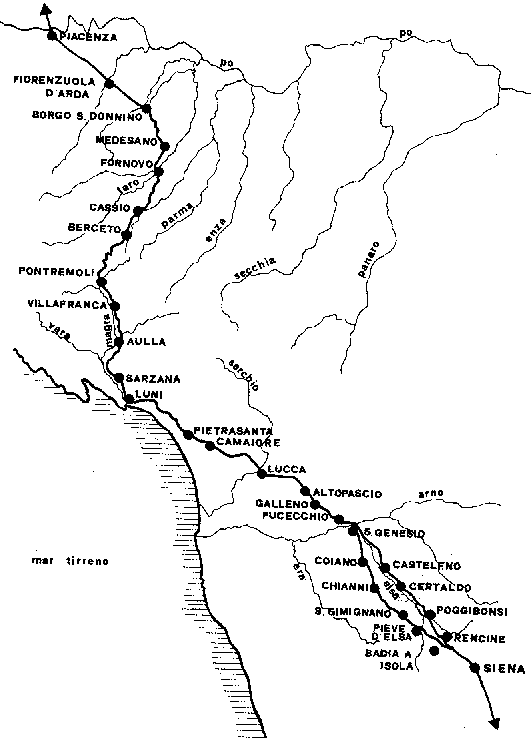
PERCORSO IN BREVE: 1. Settore occidentale dell'Appennino 2. Val di Magra e Lumi 3. Lucca 4. Alture delle Cerbaie 5. Paduli di Bientina e di Fucecchio 6. Arno 7. Asse Vallivo dell'Elsa 8. Siena 9. Valli del Merse e delI'Orcia 10. Consolare Cassia 11. Roma.
I Longobardi crearono una via tra il Regno di Pavia e la Toscana; con la dominazione franca questa via prenderà il nome di Francigena e l'itinerario diventerà più stabile. assumerà, infatti, i caratteri di una via medioevale di grande comunicazione (con abbazie regie, luoghi di sosta con strutture assistenziali); il fenomeno interesserà soprattutto il settore padano con i proseguimenti verso passi alpini come il Gran S. Bernardo, il Moncenisio e il Monginevro. La Francigena nella Pianura Padana fu un "collage" di vie romane; essa s'immetteva nella Via Emilia. Essa accrebbe la sua importanza nel secondo millennio con il florire dei pellegrinaggi verso Roma, Gerusalemme e Compostella. Lungo questa via nacquero i primi borghi, insediamenti tipici del Medioevo (a Fornovo, Ravenna, Fontanafredda ecc.) Dal XII secolo Si aggiunse anche il traffico degli uomini d'affari che utilizzavano Ia via come raccordo tra due aree mercantili (la mediterranea e quella del nord). I borghi Si estesero e nelle città ci fu una notevole crescita demografica. La Via Francigena fu uno del principali fattori dello sviluppo della vita politica, sociale ed economica del Medioevo (anche se poi fini per perdere la sua predominanza). Questo percorso rimase la strada dei pellegrini e lungo il suo itinerario si innescò un processo di socializzazione dello spazio (con chiese, cappelle ed abbazie) e un effluvio sacrale" si distese su luoghi, monumenti e manufatti.
ex internet (1report.htm)
DA FIDENZA A FORNOVO
l nostro itinerario prende dunque il passo a Fidenza: punto di convergenza e smistamento di diverse vie. A Fidenza la cattedrale riflette in modo paradigmatico la complessità architettonica, scultorea e di significato che ogni monumento medioevale porta con sé unendo l'umano e l'universale, la natura e lo spirito, il peccato e la salvezza. La maggior parte della decorazione scultorea è assegnata a Benedetto Antelami che vi avrebbe lavorato nei primissimi anni del XIII secolo. Da Fidenza per arrivare a Fornovo ed apprestarsi poi a valicare gli Appennini, il pellegrino poteva scegliere tra due vie principali. Quella più diretta lasciava la Via Claudia, come era chiamata la Via Emilia in epoca medioevale, all'altezza di Coduro, dove sorgeva la chiesa di San Leonardo, inoltrandosi nella campagna fidentina in direzione di Santa Margherita attraversando una zona denominata "la Francesca". Da qui la via punta diretto su Borghetto di Noceto, Medesano, Felegara e quindi Fornovo. Un tracciato che porta da Medesano a Felegara, infatti, è chiamato nella cartografia ottocentesca "strada comunale detta Francesca" . Forse meno frequentata ma certo non meno importante nonché suggestiva è la variante che proseguendo da Fidenza lungo la via Emilia in direzione di Parma passava per San Pancrazio, dove sorgeva la pieve con le reliquie del Santo, fino a raggiungere la Chiesa di Santa Croce alle porte della città.
Foto 1: San Simone nel Duomo di Fidenza Foto 2: Duomo di Fidenza Foto 3: Chiesa di Santa Maria Assunta a Fornovo
DA MONTEBARDONE A FORNOVO SUL TARO
A Pontremoli inizia l'ascesa del Passo della Cisa, che oggi si indentifica
con la SS 62. Il percorso, fino al secolo scorso, Si presentava come tortuoso,
difficile e attraverso fitti boschi.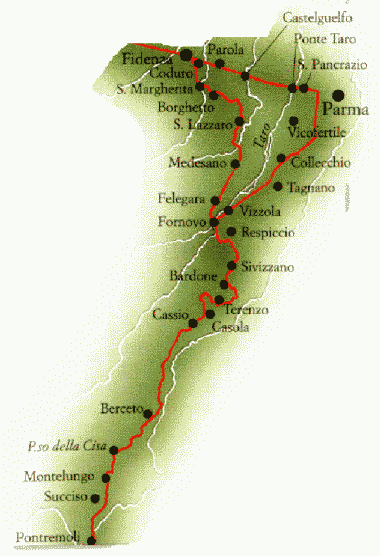 Il primo luogo della tappa era Berceto, sede di un monastero dedicato originariamente
a Sant'Abbondio, fu poi intitolata a San Moderanno, poi a San Remigio che
qui Si ritirò di ritorno da Roma costudendovi alcune reliquie. Fu
poi nominata come "S.te Moderanne" e successivamente a Saint Moran, infine
concesso alla chiesa di Parma e acquisì il titolo di "Duomo", tuttora
in uso. In questa magnifica abbazia più volte ristrutturata, i pellegrini
trovavano accoglienza e sostegno spirituale dalle reliquie di S. Remigio.
La sicurezza della mansione di Berceto, era accresciuta da un castello
ormai distrutto e anche oggi in paese e' possibile notare caratteristiche
medioevali, come la pavimentazione in pietra di alcune strade. La via dei
pellegrini toccava poi i villaggi di Castellonchio, Cassio, Terenzo e la
pieve di Bardone, con Ia sua chiesa artisticamente notevole. Si proseguiva
quindi verso Fornovo poi Segalara e Respiccio. Il primo fu uno dei nodi
della viabilità medioevale, costituendo il punto di attraversamento
del Taro e su cui convergevano, oltre la Francigena, altri percorsi. Il
luogo fu sede di una chiesa plebana dedicata a Santa Maria Assunta fin
dal secolo XI che assunse, per Ta sua importanza, il titolo di Duomo. Viene
attribuita generalmente ad un eremita del 1170 la costruzione del ponte
sul Taro assieme a cui nacque uno ospedale per i pellegrini intitolato
a S. Nicolò. Oggi di questo ponte, devastato e ricostruito più
volte, non rimangono che poche tracce. Anche della "Domus" con l'ospedale
per i pellegrini non rimane più nulla se non un affresco nel castello
di Torrechiara.
Il primo luogo della tappa era Berceto, sede di un monastero dedicato originariamente
a Sant'Abbondio, fu poi intitolata a San Moderanno, poi a San Remigio che
qui Si ritirò di ritorno da Roma costudendovi alcune reliquie. Fu
poi nominata come "S.te Moderanne" e successivamente a Saint Moran, infine
concesso alla chiesa di Parma e acquisì il titolo di "Duomo", tuttora
in uso. In questa magnifica abbazia più volte ristrutturata, i pellegrini
trovavano accoglienza e sostegno spirituale dalle reliquie di S. Remigio.
La sicurezza della mansione di Berceto, era accresciuta da un castello
ormai distrutto e anche oggi in paese e' possibile notare caratteristiche
medioevali, come la pavimentazione in pietra di alcune strade. La via dei
pellegrini toccava poi i villaggi di Castellonchio, Cassio, Terenzo e la
pieve di Bardone, con Ia sua chiesa artisticamente notevole. Si proseguiva
quindi verso Fornovo poi Segalara e Respiccio. Il primo fu uno dei nodi
della viabilità medioevale, costituendo il punto di attraversamento
del Taro e su cui convergevano, oltre la Francigena, altri percorsi. Il
luogo fu sede di una chiesa plebana dedicata a Santa Maria Assunta fin
dal secolo XI che assunse, per Ta sua importanza, il titolo di Duomo. Viene
attribuita generalmente ad un eremita del 1170 la costruzione del ponte
sul Taro assieme a cui nacque uno ospedale per i pellegrini intitolato
a S. Nicolò. Oggi di questo ponte, devastato e ricostruito più
volte, non rimangono che poche tracce. Anche della "Domus" con l'ospedale
per i pellegrini non rimane più nulla se non un affresco nel castello
di Torrechiara.
DA FORNOVO A BORGO SAN DONNINO
La via Francigena proseguiva in direzione nord correndo pressappoco
lungo il corso del fiume Taro. Il primo punto di sosta era Felegara sede
di uno spedale intitolato a San Ginesio. Il successivo punto di sosta era
Medesano dove, alla fine del 1200 vi erano due spedali dedicati a S. Lorenzo
e S. Giacomo La via proseguiva poi toccando gli abitati di Costamezzana,
San Lazzaro, Borghetto, San Maraflo, Santa Margherita e Codiro. Il percorso
era punteggiato di spedali: quello di S. Stefano presso il guado del torrente
Recchio a Coduro (spedale di S. Leonardo) e a Cabriolo la "Domus del Carobiolo".
II tracciato si svolgeva per un paesaggio lievemente ondulato fatto di
basse colline, più elevate rispetto al territorio pianeggiante che
metteva al riparo dalle inondazioni del Po. Arrivati a Borgo San Donnino
la via Francigena Si innestava nella via Emilia. La via giungeva a quella
che nel Medioevo fu una delle principali tappe della via Francigena: la
cattedrale sorta sulla tomba del martire Donnino, primo nucleo attorno
al quale Si sviluppo il borgo. Nell'anno 291, Donnino perseguitato per
la sua fede cristiana dall'imperatore Massimiano Erculeo, secondo la tradizione,
dopo essere stato decapitato, Si alzò, raccolse la propria testa,
guadò il torrente che allora bagnava il villaggio e raggiunta 1'altra
riva si pose a giacere. Sulla sua tomba sorse la chiesa che richiamò
molti devoti attratti dalla fama di guarigioni miracolose operate dal martire
che si segnalò come protettore dei viandanti. La chiesa di San Donnino
fu prima meta di pellegrinaggi locali, in seguito divenne una tappa importante
della via Francigena Attorno alla chiesa nacque un borgo di notevole consistenza
demografica che fu raso al suolo dopo varie devastazioni per l'autonomia
nel 1152 e nel 1268. Per questo la città è andata perduta,
rimane però ancora il Duomo. La chiesa è un esempio di stile
romanico padano. Sulla facciata Si trovano svariate raffigurazioni riferite
al pellegrinaggio, scene di vita di S. Donnino, messaggi rivolti ai pellegrini
e sulla colonna posta tra II portone centrale e quello di sinistra l'Apostolo
Simone che indica che quella era la via per andare a Roma. Sul campanile
sono invece raffigurati i Re Magi ritenuti i primi pellegrini della storia.
Tutti i viandanti e i pellegrini potevano trovare accoglienza nelle diverse
strutture della città tra le quali vi era anche uno spedale per
lebbrosi.
DAL BORGO SAN DONNINO AL PASSO DEL P0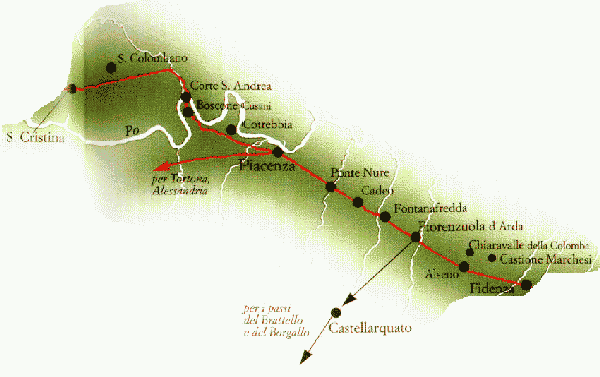
L'ITINERARIO PARMENSE
La
Via Francigena entrava in territorio parmense a Fiorenzuola, a Coduro abbandonava
la via Emilia in direzione di S. Margherita e giungeva a Fornovo sul fiume
Taro dove convergeva la variante che a S. Pancrazio si staccava dalla via
Emilia e toccava Parma. Da Fornovo la via s'inoltrava sugli Appennini per
giungere a Berceto. Attraversato il Passo della Cisa si giungeva a Pontremoli
nella valle del Magra. La provincia di Parma era attraversata anche da
un tratto alternativo che da Fiorenzuola giungeva a Bardi poi a Borgotaro
e, attraverso il Passo del Bretello a Pontremoli. Gli "Statuta Communis
Parmae" elencano le comunità tenute alla custodia della "strada
del Bardono". Infatti, i tracciati già in epoca longobarda erano
segnati dalla presenza di una serie di monasteri di cui però restano
poche tracce. Accanto a questi sorsero xenodochi e ospitales, per lo più
istituzioni religiose stabili gestite spesso da ordini monastici specializzati;
erano luogo di riparo e ristoro per l'animo per i pellegrini spossati dalla
fatica del percorso. La densità territoriale di queste strutture
è notevolissima: da Fornovo alla Cisa si ha notizia di diciotto
xenodochi nel XIV secolo. A partire da episodi che paiono eccezionali è
proprio la Via Francigena a dare testimonianza della circolazione della
cultura artistica secondo una comune matrice, simbolo di un'unità
culturale europea. Ci concentriamo ora sui borghi e gli edifici legati
al cammino dei pellegrini nei tre tracciati: da Fidenza a Fornovo, da Parma
al Passo della Cisa, da Fiorenzuola al Passo del Bratello.
DA FIDENZA A FORNOVO
 FIDENZA.
Qui inizia l'itinerario parmense. La "mansio fidentiae" romana era in origine
una stazione di secondaria importanza lungo la Via Emilia tra Piacenza
e Parma. La città ebbe grande impulso a partire dal VIII-IX sec.
Con la denominazione di Borgo S. Donnino proprio per la posizione strategica
lungo l'asse viario Francigeno. Frequenti sono state tra il XI e XIII sec.
le distruzioni e le ricostruzioni per le lotte per il dominio della via
di comunicazione tra Parma e Piacenza e successivamente tra famiglie feudali
tra le quali i Pallavicino. Si contano, infatti, almeno otto stratificazioni
delle mure cittadine, le ultime sono quelle fatte costruire dai Farnese
nel 1575. Il duomo dedicato a S. Donnino, di cui conserva le spoglie, è
uno dei massimi esempi dell'architettura romanica al quale operò
un grande protagonista dell'arte medioevale in Italia settentrionale che
è Benedetto Antelami.
FIDENZA.
Qui inizia l'itinerario parmense. La "mansio fidentiae" romana era in origine
una stazione di secondaria importanza lungo la Via Emilia tra Piacenza
e Parma. La città ebbe grande impulso a partire dal VIII-IX sec.
Con la denominazione di Borgo S. Donnino proprio per la posizione strategica
lungo l'asse viario Francigeno. Frequenti sono state tra il XI e XIII sec.
le distruzioni e le ricostruzioni per le lotte per il dominio della via
di comunicazione tra Parma e Piacenza e successivamente tra famiglie feudali
tra le quali i Pallavicino. Si contano, infatti, almeno otto stratificazioni
delle mure cittadine, le ultime sono quelle fatte costruire dai Farnese
nel 1575. Il duomo dedicato a S. Donnino, di cui conserva le spoglie, è
uno dei massimi esempi dell'architettura romanica al quale operò
un grande protagonista dell'arte medioevale in Italia settentrionale che
è Benedetto Antelami. Questo testimonia l'importanza che aveva assunto il borgo dovuta al diffondersi
della fama del santo. S.Donnino era cubicolario dell'imperatore Massimiano,
cioè era incaricato di custodire la corona, e, divenuto cristiano
si ribellò all'imperatore. Fuggito fu raggiunto tra Piacenza e Parma,
dove sorge la città, e fu decapitato nel 291. I miracoli attribuiti
al martire e raffigurati nelle sculture di facciata del duomo alimentarono
l'afflusso di pellegrini a Fidenza che divenne luogo stesso di culto. Il
duomo romanico, costruito tra il 1210 ed il 1216 e al quale collaborarono
numerosi allievi di Antelami ha un impianto basilicale a tre navate con
matronei e cripta ma la facciata è chiusa da due alte torri laterali,
l'abside centrale invece ha una struttura gotica a costoloni. E' ricco
di opere scultoree che movimentano le pareti, raccontano storie, diventano
scrigni di simboli.
Questo testimonia l'importanza che aveva assunto il borgo dovuta al diffondersi
della fama del santo. S.Donnino era cubicolario dell'imperatore Massimiano,
cioè era incaricato di custodire la corona, e, divenuto cristiano
si ribellò all'imperatore. Fuggito fu raggiunto tra Piacenza e Parma,
dove sorge la città, e fu decapitato nel 291. I miracoli attribuiti
al martire e raffigurati nelle sculture di facciata del duomo alimentarono
l'afflusso di pellegrini a Fidenza che divenne luogo stesso di culto. Il
duomo romanico, costruito tra il 1210 ed il 1216 e al quale collaborarono
numerosi allievi di Antelami ha un impianto basilicale a tre navate con
matronei e cripta ma la facciata è chiusa da due alte torri laterali,
l'abside centrale invece ha una struttura gotica a costoloni. E' ricco
di opere scultoree che movimentano le pareti, raccontano storie, diventano
scrigni di simboli. Il passaggio dei pellegrini è segnalato dai bassorilievi e altorilievi
di scuola antelamica sul lato destro della chiesa raffiguranti una teoria
di viaggiatori. Inoltre vi è una statua dell'apostolo Simone con
un cartiglio che recita: "Simon apostulus eundi Romam sanctus demonstra
hanc viam" (L'apostolo Simone indica che questa è la via per Roma).
L'Antelami è presente all'interno della cripta a tre navate con
la Madonna in trono con Bambino. Strutture di ricovero per i pellegrini
sorgeranno presso la porta S. Michele nel quartiere dei Santi Giovanni
Battista e Giovanni Evangelista. Si ricordano gli ospedali di S. Lazzaro
con all'interno la statua di S. Rocco pellegrino e di S. Iacopo CODURO.
Punto di snodo della Via Emilia, vi sorgevano la chiesa di S. Leonardo
e un ospedale ora perduti. BOGHETTO LANZABORDONI: tappa del percorso dei
romei, ma anche dei pellegrini diretti a Santiago. La via comune del paese
era, infatti, detta "Il Cammino" come era detto il pellegrinaggio in Galizia.
COSTAMEZZANA. Località detta "degli osti" per la densità
di edifici ricettivi. MEDESANO. Oltre che oggetto di interesse per la chiesa
di Lucca, il borgo fu conteso come nodo strategico sulla Via Francigena
tra il comune guelfo di Parma e l'impero. Da qui il tracciato diventa poco
leggibile per gli storici straripamenti ottocenteschi del Dordone e del
Taro.
Il passaggio dei pellegrini è segnalato dai bassorilievi e altorilievi
di scuola antelamica sul lato destro della chiesa raffiguranti una teoria
di viaggiatori. Inoltre vi è una statua dell'apostolo Simone con
un cartiglio che recita: "Simon apostulus eundi Romam sanctus demonstra
hanc viam" (L'apostolo Simone indica che questa è la via per Roma).
L'Antelami è presente all'interno della cripta a tre navate con
la Madonna in trono con Bambino. Strutture di ricovero per i pellegrini
sorgeranno presso la porta S. Michele nel quartiere dei Santi Giovanni
Battista e Giovanni Evangelista. Si ricordano gli ospedali di S. Lazzaro
con all'interno la statua di S. Rocco pellegrino e di S. Iacopo CODURO.
Punto di snodo della Via Emilia, vi sorgevano la chiesa di S. Leonardo
e un ospedale ora perduti. BOGHETTO LANZABORDONI: tappa del percorso dei
romei, ma anche dei pellegrini diretti a Santiago. La via comune del paese
era, infatti, detta "Il Cammino" come era detto il pellegrinaggio in Galizia.
COSTAMEZZANA. Località detta "degli osti" per la densità
di edifici ricettivi. MEDESANO. Oltre che oggetto di interesse per la chiesa
di Lucca, il borgo fu conteso come nodo strategico sulla Via Francigena
tra il comune guelfo di Parma e l'impero. Da qui il tracciato diventa poco
leggibile per gli storici straripamenti ottocenteschi del Dordone e del
Taro.
Fidenza (S. Simone)
DA PARMA AL PASSO DELLA CISA
S. PANCRAZIO. Da qui i pellegrini potevano
inoltrarsi verso sud senza entrare in Parma. La pieve che vi sorgeva è
stata molte volte trasformata, solo l'abside e le colonne sono da ricollegare
all'edificio originario.
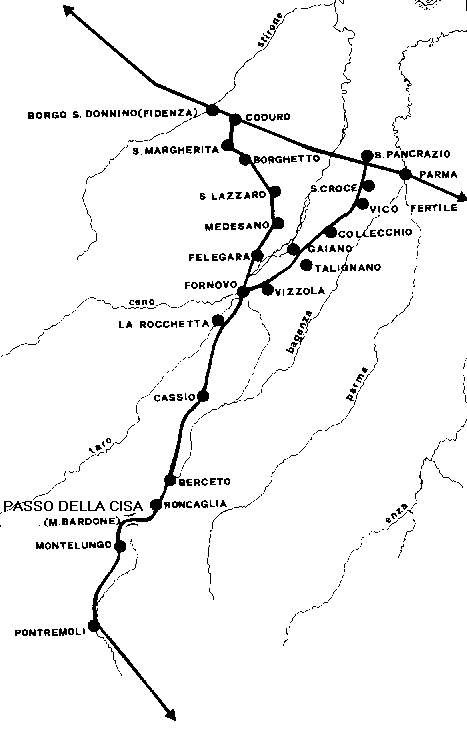
PARMA. Capitale del ducato, non ebbe una grande
importanza nel tracciato viario della Francigena che sfiorava solamente
il centro. Rimane una chiesa, fuori dalle mura, di S. Croce, " Chiesa di
via" che era collegata ad uno xenodochio e con esso costituiva un punto
di riferimento per i pellegrini. L'influenza che Parma ebbe nei comuni
francigeni fu prevalentemente economica e culturale. A livello artistico
in quanto sede della scuola antelamica dettò i linguaggi presenti
nella città del territorio.
VICOFERTILE. La chiesa dedicata a S. Geminiano
risale alla fine del IX secolo, poi ampliata nel XII. Notevole è
la vasca battesimale scolpita con figure che celebrano varie fasi della
funzione liturgica e legata all'ammaestramento dei fedeli in chiave antieretica,
soprattutto anticatara, i cui seguaci proclamavano l'inutilità di
tali riti. Sculture e capitelli di poco più tardi richiamavano i
bestiari medioevali. Sia la Chiesa, sia l'ospedale di Fra Baratino poco
distante dal borgo appartenevano al privato di S. Pancrazio.
TALIGNANO. Superato un tratto in cui sorgevano
alcune pievi, come quella di S. Nicomede contesa tra i centri di Collecchio
e di Giarola, si giungeva a Talignano. La pieve di S. Biagio, sorta probabilmente
nel XII secolo, aveva annesso un ospizio per i pellegrini ed era alla dipendenza
del monastero di S. Roberto "Ultra Hontes". D'impatto per i viandanti in
cerca di redenzione era la lunetta con la psicostasi o pesa delle anime
fatta da S. Michele in contesa col diavolo.
FORNOVO: Posto alla confluenza dei torrenti
Ceno e Taro è tappa importantissima per i pellegrini che qui trovano
luoghi di ristoro, di preghiera e di informazione prima di intraprendere
il valico dell'Appennino. Qui si univano le due direttrici da Fidenza e
da Parma. La cittadina è nota anche per essere stata teatro di una
famosa battaglia il 5 e 6 luglio 1495 tra l'esercito della Lega dei Comuni
italiani retto da Francesco Gonzaga e quello francese di Carlo VIII in
ritirata da Napoli. Da ricordare è la chiesa di S. Maria Assunta
il cui impianto originario risalente all'XI secolo e con semplice interno
a tre navate fu modificato con l'aggiunta di un Nartece con doppio colonnato
per l'accoglienza dei pellegrini. La pieve era ricca di manufatti scultorei
con precisi riferimenti alla sua collocazione, al cammino dei romei, legate
al tema del pellegrinaggio inteso in senso simbolico: testimonianza di
questo è una statua acefala sulla facciata rappresentante un pellegrino
con sette chiavi alla cintola, particolare allegorico che richiama le sette
più importanti basiliche romane che i pellegrini avrebbero dovuto
visitare una volta giunti alla meta. Molti dei rilievi trattano il tema
del peccato e della lotta tra bene e male. Legata all'universo del pellegrinaggio
è la croce in bronzo, che raffigura il Cristo crocefisso vestito
con la tunica, in chiara corrispondenza con la grande scultura, meta di
devozione, del "Volto Santo" di Lucca.
RESPICCIO. A "Rivo Spitio" si trovava la chiesa
con l'ospizio di Santa Maria Maddalena. Nel XIV secolo l'ospedale fu riparato
per continuare a raccogliere pellegrini, il che fa pensare che in questo
territorio il flusso di fedeli era ancora importante.
BARDONE. Vi si giungeva attraversando uno
scenario naturalistico, oggi ancora intatto, che sostentava lo spirito
del pellegrino e superando il monte Prinzera sul versante occidentale.
La chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, come quella di Fornovo è
una delle più antiche e vaste pievi della Diocesi parmense. I rifacimenti
di epoca Rinascimentale hanno lasciato poco dell'antica pieve, addirittura
si ipotizza che ne abbiano cambiato l'orientamento. I vari frammenti dell'apparato
scultoreo hanno evidenti legami con lo stile antelamico e con quello presente
a Fornovo.
TERENZO. Ricordiamo la chiesa di S. Stefano
le cui campane richiamavano ad un luogo sicuro i pellegrini ancora in cammino
al calare della sera, l'ospedale per i poveri, zoppi e pellegrini e la
cappella imperiale che dipendeva dai Canonici di S. Maria di Praga.
CASOLA. Il castello dei Pallavicino era un
avamposto sulla via di Monte Bardone.
SALTI DEL DIAVOLO. Conformazione geologica
disposta trasversalmente alla Val Baganza con caratteristici affioramenti
rocciosi dall'aspetto di guglie. Qui sorgeva lo xenodochio di S. Ilario.
BERCETO. Superati i caratteristici borghi di Cassio e Castellonchio si
arriva ad una delle soste più elevate dell'intero percorso francigeno.
L'impianto urbanistico odierno ha conservato l'asse viario della Francigena
che attraversava l'abitato. Questo centro svolse un compito di accoglienza
per i viatores con edifici raccolti intorno ad un'antica abbazia, voluta
dai longobardi. L'edificio attuale è a tre navate di cui la centrale
coperta con capriate e le laterali voltate a crociera, sul transetto si
innalza un tiburio a base quadrata. Preziosa la formella all'interno con
i pavoni che si abbeverano alla croce. Ai lati del portale vi sono le statue
dei Santi Pietro e Paolo i cui sepolcri a Roma erano la meta del pellegrinaggio.
Ricorre spesso il tema del peccato e il suo riscatto. La fama di Berceto
fu dovuta al vescovo Moderanno che pose nella chiesa suddetta le reliquie
del predicatore dei Franchi: S. Remigio. Quando poi il vescovo morì
venne sepolto all'interno della chiesa che gli venne dedicata. In seguito
l'edificio venne a contenere le reliquie di S. Broccardo, predicatore tedesco.
Questo testimonia "l'europeizzazione" che i pellegrinaggi determinarono
in alcuni centri. Ulteriore testimonianza viene dalla circolazione della
cultura figurativa.
CORCHIA. Borgo medievale di tipo montano in
cui sorgeva un ospedale.
PASSO DELLA CISA. La maggior parte dei pellegrini
superava gli Appennini da qui; ciò offriva il vantaggio di molto
ospizi di cui invece era privo il Passo del Cirone. Il passaggio dalla
Cisa era considerato sicuro per la presenza a turno di gruppi di uomini,
anche armati, provenienti dai paesi vicini che esercitavano il controllo
sulla via.
DA FIORENZUOLA AL PASSO DEL BRATELLO
FIORENZUOLA. Qui l'itinerario si staccava dalla
via Emilia. Nei pressi sorge l'antica abbazia cistercense di Chiaravalle
della Colomba, la cui fondazione è ipotizzata all'inizio del XII
secolo poiché già nel 1135 la località aveva preso
il nome di Chiaravallis, e il monastero di Santa Maria Colomba. Il campanile
però è tardo-cinquecentesco. La chiesa è a tre navate
con ampio transetto; notevole è il chiostro. L'importanza di Chiaravalle
è testimoniata dalle sue numerose dipendenze. CASTELL'ARQUATO. Il
periodo di massimo splendore di questo borgo medievale risale alla metà
del XII sec. quando in esso, già da tempo retto da una democrazia
comunale, il cardinale arquatese, Giacomo Della Porta, fa costruire a sue
spese la chiesa di S. Giacomo con annesso ospedale per accogliere i pellegrini
di passaggio. Da questo momento il borgo accresce la sua importanza diventando
uno dei centri toccati dalla via Francigena e per questo alcuni anni dopo
(1275) viene costruito un secondo ospedale, di S. Spirito, rimasto in attività
fino al 1920. E' così che la splendida chiesa romanica diviene testimonianza
congiunta di fede religiosa e di sviluppo economico e sociale: l'estrema
semplicità della facciata della Colleggiata contrasta con la cura
di esecuzione della parte absidale che è invece fedele alle norme
dell'architettura lombarda. Anche all'interno segue le forme tradizionali
delle basiliche a colonne con coperture in legno a vista. Altri motivi
ornamentali, come i capitelli scolpiti presentano gusti non solo longobardi
e pure barbarici ma addirittura essi sono uniti all'influsso orientale
(bizantino). Da ricordare infine anche il chiostro trecentesco, un affascinante
mistico angolo d'arte.
PASSO DEL PELLINZONE. Superato questo si entrava
in territorio parmense. Vi era anche un ospedale.
BARDI. Tra Fornovo e Bardi si ha notizia nelle
decime Piacentine di alcuni ospedali ora non più esistenti; l'ospedale
del paese era dedicato a S. Giacomo. Rimane il castello di carattere militare.
GRAVAGO. Vi sorgeva l'antico monastero di monaci benedettini dedicato all'Arcangelo
S. Michele. BORGOTARO. Borgo medievale con una pieve dedicata a S. Giorgio
dipendente dal monastero benedettino di S. Colombano di Bobbio il cui abate
trovava qui ospitalità durante i suoi viaggi per Roma.
PASSO DEL BRATELLO. E' il passo più
comodo tra quelli che si aprono dal Parmense alla Lunigiana e tra il XII
e XIII sec. intense furono le lotte tra Piacenza, Parma e i Malaspina per
il possesso del castello di Crondola che dominava la strada.
PONTREMOLI. Qui la variante si ricollegava
alla via Francigena. E' un centro importantissimo dei traffici proprio
per la confluenza di vari itinerari di valico degli Appennini.
FORNOVO
